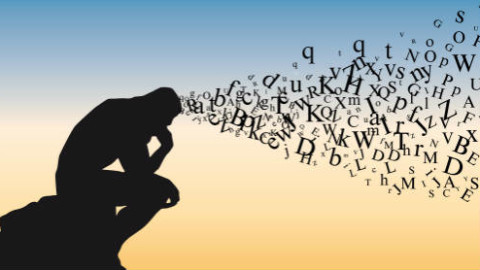di Gennaro Grimolizzi – Etica NEWS
Marzo 2013
Ambasciatore Terzi, per quanto riguarda la Corea del Nord, siamo dinnanzi a mere “provocazioni” ad uso di politica interna da parte di un paese la cui capacità offensiva è in parte sopravvalutata, oppure le minacce lanciate dal giovane dittatore sui mass-media internazionali sono realmente concrete e pericolose?
Per tre settimane abbiamo assistito a una “escalation” di toni aggressivi e di minacce da parte di Kim Jong Un, ma il regime nordcoreano non è certo nuovo a queste provocazioni. Esperimenti nucleari, limitati attacchi di artiglieria sulla linea di confine, e persino l’affondamento di una corvetta sudcoreana – con numerose vittime – hanno costellato la storia degli ultimi anni. Verrebbe quindi da pensare che il giovane Leader si muova nella stessa logica del padre: quella di mostrare i muscoli per sollecitare l’occidente a “comprare” stabilità mediante l’assegnazione di aiuti economici. Inoltre questa strategia gli garantisce l’indispensabile sostegno del suo gigantesco apparato militare, e tiene coesa una popolazione martellata dalla propaganda nazionalista. Vi sono però in questa crisi motivi di accresciuta preoccupazione che rendono la minaccia da non sottovalutare. Il primo riguarda il tipo di arma sperimentata nell’ultimo test nucleare: a quanto è dato sapere è una bomba più potente e più affidabile, nonostante permangano dubbi sulla reale gittata dei missili Musudan. In secondo luogo, Kim Jong Un ha l’intenzione di produrre altri ordigni, anche al plutonio, riattivando il reattore di Yongbyon. Infine, egli ha preso una serie di misure inedite: la chiusura di fatto del parco industriale di Kaesong, gestito congiuntamente dalle due Coree, e la denuncia dell’armistizio del ’53, dimostrano il suo definitivo allontanamento da quella linea di faticose anche se piccole “prove di dialogo” volute a Seoul e a Washington. Le due capitali stanno seguendo una strategia attenta a dare al Nord l’esatta percezione della risposta che seguirebbe a iniziative ancor più avventate di Kim: la Presidente Park Geun Hye ha parlato di risposta automatica e proporzionale, Seoul vuole sgombrare il campo da quella controproducente incertezza che aveva frenato la reazione sudcoreana all’affondamento della corvetta sudcoreana Cheonan, e Washington ha spiegato difese antimissile e aerei a doppia capacità. Ora sul piano diplomatico si sta facendo di tutto per lasciare una via d’uscita a Kim, cercando di far scendere i toni e rilanciando l’obiettivo della denuclearizzazione dell’intera penisola.
Quale potrebbe essere una possibile via d’uscita da questa escalation?
Come paiono dimostrare le blande aperture di queste ultime ore, a mio avviso la chiave della soluzione è a Pechino. Non solo perché – come alcuni pensano – è possibile che la crisi sia nata anche per far comprendere ai cinesi che la Corea del Nord è “diventata adulta”, che vuole essere considerata a tutti gli effetti parte del “club nucleare”, e che non intende subire più di tanto pressioni neppure da Pechino. Ricordiamo come nel settembre 2005 si fosse usciti da un’analoga impasse grazie alle pressioni cinesi su Pyongyang durante i “Six Party Talks” (i colloqui a sei per gli accordi di denuclearizzazione della penisola coreana, ndr). Xi Jinping sembra consapevole sia dei rischi sia delle opportunità di questo scenario. Rischi, perché una conflagrazione impatterebbe pesantemente su quel decennio di “crescita armoniosa” che la nuova leadership cinese ritiene assolutamente necessaria per consolidare il proprio ruolo globale; opportunità, perché – lo aveva subito spiegato Obama a Xi, al momento dell’invio dei bombardieri e dei sistemi e antimissile – un allentamento della tensione rimuoverebbe la causa immediata del rafforzato e urgente spiegamento militare americano nell’area, sicuramente sgradito a Pechino. Questa crisi sta piuttosto rappresentando secondo me il banco di prova di un solido e strutturato dialogo strategico tra Cina e Stati Uniti, un dialogo che può mirare alla definizione di misure di fiducia e a verifiche e consultazioni su temi politici e militari della massima importanza. Mezzo secolo di Guerra Fredda ha dimostrato come si possa raggiungere una condizione di stabilità e di equilibrio strategico tra blocchi dichiaratamente nemici sulle base di regole negoziate e di comportamenti verificabili. Non vi è motivo perché ciò non possa avvenire oggi, in un teatro completamente diverso, ma questa volta con un grande paese partner e non nemico degli Usa e dell’Occidente.
Diversi osservatori hanno parlato di “euro-egoismi” nelle politiche Comunitarie dell’Unione. Il Mediterraneo ha perso la sua centralità politica ed economica sullo scacchiere mondiale? Come si può invertire la rotta?
Gli “euroegoismi”, se così vogliamo chiamare un certo “strabismo” dell’Unione non sempre a favore del Mediterraneo, emergono da diversi aspetti delle politiche Europee: misure per la crescita, attuazione dell’Unione Bancaria, impostazione del bilancio 2014-2020, per citare alcuni degli esempi che hanno dimostrato ancora nelle ultime settimane il prevalere di una linea ispirata tendenzialmente dalla Germania a da alcuni altri partner nord e centroeuropei. Una vera strategia UE per il Mediterraneo è stata per contro una vera costante dell’azione diplomatica Italiana a Bruxelles, e nell’ultimo anno sono stati conseguiti risultati di rilievo: di bilancio, con l’aumento di fondi destinati ai Paesi delle Primavere arabe, istituzionali, avviando missioni UE di consolidamento delle istituzioni e di assistenza tecnica in Libia e in Mali, e politici, interagendo costruttivamente nei processi costituzionali in Egitto, Tunisia e Libia. Inoltre l’Italia ha contributo a integrare nella visione di “politica estera” dell’Unione le tematiche migratorie e di sviluppo: l’impegno europeo per la stabilità di tutta l’area mediterranea, per la sua crescita economica e per l’affermazione di Stati di diritto deve tuttavia essere non solo proseguito ma decisamente rafforzato.
Quali i motivi salienti per porre questi aspetti in cima all’agenda UE?
Perché si tratta di fatto di una grande regione sempre più integrata economicamente con l’Europa. Solo per l’Italia, ad esempio, essa rappresenta un interscambio di 80 miliardi di Euro e lavoro per migliaia di nostre aziende, e nonostante le vicende per certi versi turbolente che hanno caratterizzato gli ultimi due anni i mercati del “Grande Mediterraneo” – dell’area cioè che va dal Marocco al Golfo Persico – il nostro export ha registrato nel 2012 un incremento di circa il 20%. Una ragione altrettanto importante per sostenere un decisivo e urgente rafforzamento dei partenariati euromediterranei riguarda la sicurezza e le prospettive positive offerte da una cultura di dialogo e d’integrazione: il fondamentale interesse che tutti i cittadini europei dovrebbero avvertire affinché si consolidino nella sponda sud del Mediterraneo società democratiche, pluraliste, rispettose dei diritti umani e delle libertà fondamentali dell’individuo, a partire da quella di religione, è evidente agli occhi di tutti, in termini di maggiore stabilità anche ai nostri confini.
Il recente viaggio del Presidente Obama in Israele e nei Territori palestinesi non pare aver dato i frutti sperati, e il dialogo di pace in Medio Oriente è in fase di stallo da due anni e mezzo circa. Come si potrebbe uscire a suo avviso da questa situazione?
La visita del Presidente Obama e del Segretario di Stato Kerry in Israele e Palestina all’indomani della formazione del nuovo Governo israeliano aveva un obiettivo ben mirato nelle aspettative, e lo aveva ben precisato Kerry negli incontri con i Ministri europei e atlantici che io stesso avevo ospitato a Villa Madama proprio a fine febbraio. In questo senso, la missione di Obama mi sembra aver centrato alcuni obiettivi. In primis, quello di sottolineare in modo solenne con questa sua prima visita in Israele l’impegno irremovibile degli Stati Uniti a garantire la sicurezza e l’esistenza dello Stato di Israele, in particolare dinanzi alla minaccia di un programma nucleare iraniano con asserite finalità militari. Vi è chi ha visto in questa rinnovata “garanzia” l’intenzione americana di convincere Gerusalemme della validità dell’approccio seguito con Teheran: una crescente pressione sanzionatoria combinata nel contempo con reiterati appelli al negoziato, anche al fine di stemperare per i prossimi mesi le tentazioni di operazioni militari in quell’area.
Il secondo obiettivo riguardava invece il rapporto con i palestinesi: l’Amministrazione Usa condivide con i Governi europei che lo status quo non stia “tenendo”, soprattutto a fronte di una continua espansione degli insediamenti israeliani a West Bank. La visita del Presidente sembra aver prodotto qualche apertura israeliana per un “self restraint” su questo versante, mentre i palestinesi si asterrebbero per ora da nuove iniziative in sede Onu tese a consolidare la statualità palestinese e al tempo stesso a mettere in qualche difficoltà Israele sugli aspetti giuridici dell’occupazione dei Territori. Esiti questi certamente limitati, ma che dovrebbero essere la premessa per un’azione del Segretario di Stato volta a riannodare il dialogo, partendo ad esempio dalle misure che maggiormente interessano la critica situazione economica palestinese. Ma non vorrei trascurare un altro aspetto di quella visita, a mio giudizio – forse – il più significativo sul fronte diplomatico: Obama è riuscito a rasserenare il rapporto tra Gerusalemme e Ankara, gravemente compromesso dall’incidente della nave bloccata con la forza dalla marina israeliana al largo di Gaza a fine 2008. Il superamento di quella vicenda può ora riportare i rapporti tra questi due Paesi, essenziali protagonisti nella regione, a un grado di collaborazione adeguato affinché le crisi che si stanno sviluppando sui loro confini vengano affrontate in modo costruttivo anziché antagonistico. Per l’Italia, paese cosi amico di entrambi, si tratta quindi di uno sviluppo decisamente positivo.
La crisi siriana sembra non avere sbocchi, e le violenze continuano. La comunità internazionale deve ancora attendere?
La guerra civile siriana sta assumendo connotazioni sempre più radicali, settarie e destabilizzanti per i paesi vicini, e realmente catastrofica per le popolazioni coinvolte. Dopo due anni dall’inizio del conflitto, sono settantamila i morti, tra i quali un numero elevatissimo di bambini, e superano i cinque milioni quanti hanno dovuto lasciare le proprie case, praticamente un siriano su quattro, con un milione di rifugiati in Turchia, Giordania e Libano. Inoltre, un’applicazione anche solo embrionale del principio Onu sulla “Responsabilità di proteggere” è bloccato dalle riserve Russe e Cinesi in sede di Consiglio di Sicurezza Onu, che costituisce il naturale quadro di legalità per eventualmente autorizzare i Paesi che fossero disposti a farlo a creare una zona almeno parziale di interdizione ai voli e ai bombardamenti del regime di Assad, una “no fly zone umanitaria”.
La comunità internazionale – o per lo meno i Paesi che avvertono più direttamente i rischi diretti e le responsabilità derivanti dalla crisi siriana – stanno cercando di muoversi per altre strade?
Certamente, l’azione diplomatica segue diverse opzioni, tra loro in una certa misura collegate. Nel contesto Onu prosegue la cosiddetta “Iniziativa di Ginevra”, sostenuta da diversi paesi e – in questo caso – anche dalla Russia: da mesi si sta cercando di avviare un dialogo diretto tra le opposizioni e il regime, in modo da giungere alla formazione di un Governo provvisorio di unità nazionale. Il problema è che dopo i massacri di civili le forze veramente anti-Assad – e dico “veramente” per distinguerle da gruppi di oppositori ritenuti “addomesticati” – non accettano ormai in alcun modo di trattare prima che il Presidente abbia lasciato il potere. Si è quindi sviluppato un percorso alternativo, sostenuto da più di cento Paesi – europei, africani, arabi, asiatici – di cui la Lega araba è una delle componenti significative, in sostegno all’opposizione siriana: l’obiettivo, in discreta misura già conseguito, è quello di incoraggiare e aiutare la Coalizione dei gruppi di opposizione a esprimere una propria leadership di ispirazione moderata e impegnata a fare della nuova Siria un paese rispettoso del pluralismo. Alla riunione di Roma di fine febbraio, undici Paesi si sono impegnati a proseguire in questa direzione con particolare intensità, rilanciando i loro sforzi diplomatici e di assistenza: oltre all’Italia, gli Usa, la Gran Bretagna, la Francia, la Germania, la Giordania, la Turchia, l’Egitto, l’Arabia Saudita, il Qatar e gli Emirati Arabi. Si tratta di un “core group” che deve essere guidato da un’agenda comune e da una comune volontà politica: il raccordo tra questi Paesi e la Coalizione dell’opposizione siriana deve trovare un modo per far cessare i massacri della guerra civile, e avviare una vera e propria riconciliazione nazionale. L’alternativa rischia di essere la “cronicizzazione” di un conflitto in chiave anti-Assad, conflitto che potrebbe durare nel tempo e propagarsi nella regione, anche con un pericoloso e progressivo radicamento del Jihadismo.
Sono note le polemiche post- invasione dell’Iraq circa l’esistenza o meno di armi di distruzione di massa. Rischiamo anche con la Siria una sovra-valutazione del rischio, o il pericolo è concreto?
L’abbinamento tra movimenti terroristici e armi di distruzione di massa costituisce la più grave minaccia immaginabile per la sicurezza dei nostri paesi e dei nostri concittadini, minaccia con la quale probabilmente dovremo continuare a confrontarci per molto tempo. La Siria è diventata un potente possibile “diffusore” di entrambe. Erano molti coloro che – due anni orsono, assistendo inorriditi ai primi spari delle forze speciali di Assad su cittadini e dimostranti – ammonivano il mondo a impegnarsi per far cessare quello scempio, al fine di evitare lo scoppio di una vera e propria guerra civile e il conseguente radicamento, dentro e fuori la Siria, di possibili formazioni terroristiche: ciò poi è puntualmente avvenuto. Le medesime preoccupazioni riguardano l’arsenale di armi chimiche in disponibilità del regime. Non si tratta qui di generici allarmi sull’”eventuale” presenza di armi chimiche: di questi ordigni sono conosciute le caratteristiche, la localizzazione e la disponibilità ai singoli reparti militari. Gli Usa e i principali Paesi europei, tra i quali l’Italia, ma anche la stessa Russia, hanno ripetutamente e con estrema chiarezza avvertito Assad che l’utilizzo di queste armi non sarà in alcun modo tollerato. Stesso dicasi per trasferimenti di armi chimiche ad entità diverse da quelle siriane, come ad esempio le formazioni dell’Hetzbollah libanese che operano in misura non trascurabile in appoggio alle forze del regime. Vero è che l’errore commesso nel 2003 dall’intelligence di alcuni paesi nel ritenere che Saddam Hussein disponesse di una capacità di offesa nucleare o almeno di un programma nucleare segreto – che peraltro il dittatore stesso faceva di tutto per rendere credibile a fini di propaganda – sono un precedente che obbliga alla massima prudenza nel valutare l’esatta consistenza di questo tipo di minaccia, ma nel caso siriano posso confermare che le prove dell’esistenza di questo tipo di arsenali sono purtroppo inconfutabili, con rapporti dei servizi informativi che provengono da Governi che hanno anche posizioni tra loro assai diverse sulla questione siriana.
Due anni fa veniva ucciso Osama Bin Laden. Il mondo, dopo la sua eliminazione, è davvero più sicuro?
La scomparsa di Bin Laden è stata sicuramente un durissimo colpo per Al Qaeda, per nulla solo simbolico, anche perché non si è trattato di un successo isolato ma piuttosto del tassello di un insieme che ha permesso l’eliminazione di molti livelli organizzativi e di comando dell’intera rete terroristica. Se la struttura collegata a Bin Laden e a Zawahiri ha sofferto, i terroristi che si collegano anche ad Al Qaeda cercano però nuove opportunità, soprattutto in Afghanistan, Pakistan e Yemen, in regioni come il Sahel, e probabilmente in Siria, Iraq, e Nigeria. Si tratta di denominazioni diverse, di leader jihadisti che sfruttano scenari locali come ad esempio la destabilizzazione in Mali, i movimenti indipendentisti Tuareg dell’Azawad, il settarismo antireligioso di Boko Haram in Nigeria, per rafforzarsi attraverso i sequestri e ogni tipo di traffici legati anche alla criminalità comune.
Quali i mezzi più efficaci per affrontare questa emergenza?
Sul tema terrorismo come ho detto non dobbiamo mai abbassare la guardia, e i recenti fatti di Boston – se mai fosse necessario – lo confermano. E’ una sfida per affrontare la quale dobbiamo disporre di volontà politica, capacità tecnica di prevenzione, e strumenti efficaci di intervento. I principi democratici nei quali crediamo dimostrano che possiamo superare queste prove nello scrupoloso rispetto delle norme costituzionali e dei valori fondanti del nostro Paese, con riguardo per la tutela della dignità della persona e il rispetto delle garanzie previste dalla legge. Un esempio mi pare particolarmente calzante, perché accaduto proprio a casa nostra: l’Italia è diventata una democrazia ancor più fortemente consapevole dopo aver debellato le Brigate Rosse e i nuclei armati di altre organizzazioni estremiste con strumenti derivati dalla Costituzione della Repubblica e nel pieno rispetto delle norme. Ebbene, deve valere il medesimo principio nella collaborazione internazionale per la lotta al terrorismo: l’Onu, l’Ue, la Nato, le organizzazioni regionali come l’Unione Africana, l’Ecowas, l’Osa e altre, promuovono – in diverse forme e intensità – questa preziosa collaborazione. La minaccia terroristica è come un’infezione pandemica: cambia forma, si tramuta e può anche reagire efficacemente agli anticorpi. Ma – come ogni infezione – può e deve essere debellata, a condizione che le società minacciate da essa mantengano intatta la loro determinazione a reagire con immediatezza, fermezza, e nel rispetto delle regole democratiche, come stiamo ad esempio vedendo in questi giorni a Boston e in tutti gli Stati Uniti.
Quali sono a Suo avviso gli impegni principali che il prossimo Ministro degli Esteri, con la creazione del nuovo Governo, dovrebbe mettere prioritariamente in agenda?
La politica estera italiana ha nel suo DNA il carattere della continuità e della coerenza verso l’Alleanza Atlantica, l’Europa, i partner mediterranei, la tutela dell’interesse nazionale e la valorizzazione di quella straordinaria realtà rappresentata dai nostri connazionali nel mondo. E’ una politica estera caratterizzata da forti contenuti valoriali. Non potrebbe essere diversamente, per un paese dove lo spirito di libertà ha alimentato il Risorgimento e la nostra unità nazionale, e dove la solidarietà sociale, la sensibilità per i diritti umani e la dignità dell’uomo, l’impulso a sostenere lo sviluppo e a lottare contro la povertà, costituiscono priorità fortemente avvertite da tutta l’opinione pubblica. Per questo motivo la politica estera, forse più di altri ambiti dell’azione di Governo, ha le potenzialità per essere condivisa e sostenuta da un ampio schieramento parlamentare. All’interno di questo positivo contesto, credo che il Ministro degli Esteri del prossimo Governo avrà certamente modo di rafforzare ulteriormente il ruolo del nostro Paese in Europa, nella Comunità Atlantica e a livello globale. Un anno di intensissimo lavoro alla Farnesina, con quasi millecinquecento incontri ed eventi che hanno riguardato novantuno paesi diversi, mi hanno convito che c’è una visibile e crescente “richiesta di Italia” nel mondo. In regioni come i Balcani, ad esempio, dove si conta moltissimo sulla prosecuzione dell’impegno assunto dalla diplomazia italiana per rendere concrete le prospettive europee di paesi come l’Albania, la Serbia, il Montenegro, la Macedonia, processi di inclusione che hanno stabilizzato un’intera regione fino a pochi anni fa molto turbolenta. Nel Mediterraneo orientale, grazie al nostro straordinario rapporto con Turchia, Israele, Libano ed Egitto. Sulla riva sud del Mediterraneo, dove siamo il primo Paese nei programmi di consolidamento istituzionale e di stabilizzazione della Libia, con relazioni fiorenti anche con Algeria, Marocco e Tunisia. Anche il sostegno all’uscita della Somalia da una ventennale anarchia statuale, processo che ho stimolato con grande impegno nella mia visita a Mogadiscio e in tutte le iniziative a favore di quel paese, deve restare tra le primissime priorità del futuro Governo, perché l’intero corno d’Africa può beneficiarne. Faccio questi pochi esempi che riguardano aspetti “tradizionali” della nostra politica estera, ma potrei continuare a lungo.
Appare chiara anche l’importanza che la comunità internazionale attribuisce alla nostra partecipazione alle operazioni di pace nelle aree di crisi, e al ruolo della nostra diplomazia in tali contesti…
Certo, e per questo siamo stati sollecitati a essere parte attiva nella ricerca di una soluzione alla tragedia siriana, alla ricostruzione della Libia, alla guida di Unifil in Libano, a contribuire alla stabilizzazione del Mali, mentre siamo e continueremo a essere ascoltati nel processo di pace in Medio Oriente. Ma vi sono anche altri aspetti meno “tradizionali” della nostra politica estera ma egualmente importantissimi: la tutela dei diritti umani, della libertà di religione, la lotta contro la pena di morte e contro le mutilazioni genitali femminili vedono da anni nell’Italia un protagonista di assoluto primo piano a livello internazionale. Continueremo certamente a esserlo, dando continuità – ne sono fiducioso – a quanto abbiamo realizzato nell’ultimo anno anche alle Nazioni Unite e all’Unione Europea, con il lancio di iniziative dedicate a tali obiettivi.
Lei ha parlato di Italia come di “superpotenza culturale”. Può approfondire brevemente questo concetto?
La Farnesina ha lanciato nell’ultimo anno con sistematicità iniziative e programmi mirati a valorizzare la nostra cultura come “soft power” in politica estera e l'”economia della cultura” intesa anche come motore di crescita e d’internazionalizzazione per le nostre imprese. Abbiamo collaborato con realtà associative all’estero per ottenere in alcuni paesi, come ad esempio gli Stati Uniti, un vero e proprio salto di qualità nell’ insegnamento della lingua italiana, e ci siamo adoperati per collegare, con iniziative concrete, il mondo della ricerca e dell’impresa in Italia con i ricercatori italiani operanti all’estero, grazie all’attivazione di piattaforme informatiche a ciò dedicate. La cultura del nostro Paese e le comunità degli italiani nel mondo sono due immense risorse sulle quali, a mio avviso, deve essere basata l’architettura dell’intero sistema di politica estera del Paese.
Ha più volte fatto notare in interviste alla stampa un certo sottodimensionamento dell’amministrazione degli Esteri in Italia rispetto ad altri partner Europei: conferma questo limite?
Si, ed è inderogabile un profondo riallineamento delle risorse disponibili per l’Amministrazione degli Esteri. Questo riguarda i fondi e il personale – la metà di quelli a disposizione di altre nazioni europee – ma anche la centralità della Farnesina, centralità che va assolutamente ribadita. La creazione con il Governo Monti di separati Dicasteri per gli Esteri, la Cooperazione e gli Affari Europei non è purtroppo andata nella direzione nella quale si sono mossi tutti gli altri principali paesi europei: ha creato difficoltà funzionali, sovrapposizioni e scollamenti operativi che dovrebbero immediatamente essere eliminati all’atto della formazione del nuovo Governo. La cooperazione è parte integrante della politica estera di un Paese, e l’organizzazione di Governo deve riflettere questo principio. Il disegno di Legge di riforma del settore in itinere nella passata legislatura riconosceva appunto questa esigenza. Tema forse più complesso riguarda gli Affari Europei, ma se guardiamo ad esempio a paesi come la Francia, il Ministro che riveste tali competenze è associato al Ministro degli Esteri e non al Primo Ministro: in tal modo si crea una utile osmosi tra il livello bilaterale e il livello multilaterale della nostra politica estera in Europa e per l’Europa, con un raccordo funzionale ordinato attraverso la rete diplomatica nelle capitali UE e a Bruxelles.
Un’ultima domanda, inevitabile, dal momento che ci troviamo su un mezzo d’informazione digitale. Lei è stato l’unico membro dell’esecutivo ad utilizzare con quotidiana frequenza sia Twitter che Facebook, ed è stato definito un “Ministro social”, capace di integrare con efficacia – sui temi della politica estera – mass-media convenzionali e digitali. Perché questa scelta?
Perché – come ho detto nel libro “Caro Ministro”, che ben riassume un anno di politica estera anche sui digital media – penso che Twitter e Facebook e in generale le piattaforme di confronto on-line siano oggi strumenti essenziali per un’attività di Governo, ancor di più per un Ministro degli Esteri. Non ci sono arrivato improvvisamente, è stata una convinzione maturata già da Ambasciatore alle Nazioni Unite e a Washington, diversi colleghi di Paesi importanti usavano i social media con successo. Nel momento in cui ho assunto la guida della Farnesina ho quindi attivato sempre più le nuove forme di comunicazione, nominando anche un Consigliere con delega specifica ad affiancarmi in queste strategie, e ricavandone elementi preziosi in termini di approfondimenti e di conoscenza della sensibilità della pubblica opinione sulle varie tematiche. Bisogna “vivere” i dibattiti, le conversazioni che si sviluppano in modo da poter dare ogni giorno qualche, sintetico segnale sui punti di spicco dell’agenda di politica estera del Paese. Chi mi segue su Twitter e Facebook sa bene che quotidianamente cercavo di riservare qualche minuto della giornata per dare impulsi sulle cose che stavo facendo, sulle questioni che stava discutendo il Governo nei campi rilevanti della politica estera, della politica europea, della sicurezza internazionale, e sto continuando a farlo sia su Twitter che sulla mia pagina Facebook. Il web non è un sistema alternativo all’insostituibile patrimonio di esperienza, cultura ed equilibrio interno all’Amministrazione pubblica, ma lo completa. La diplomazia e la politica estera non devono aver paura dei social network: il web influisce sulle trasformazioni di tutta la società, quindi dobbiamo mettere da parte i timori, e capire come poter governare al meglio queste nuove e fluide sfide digitali.
 wikipedia
wikipedia